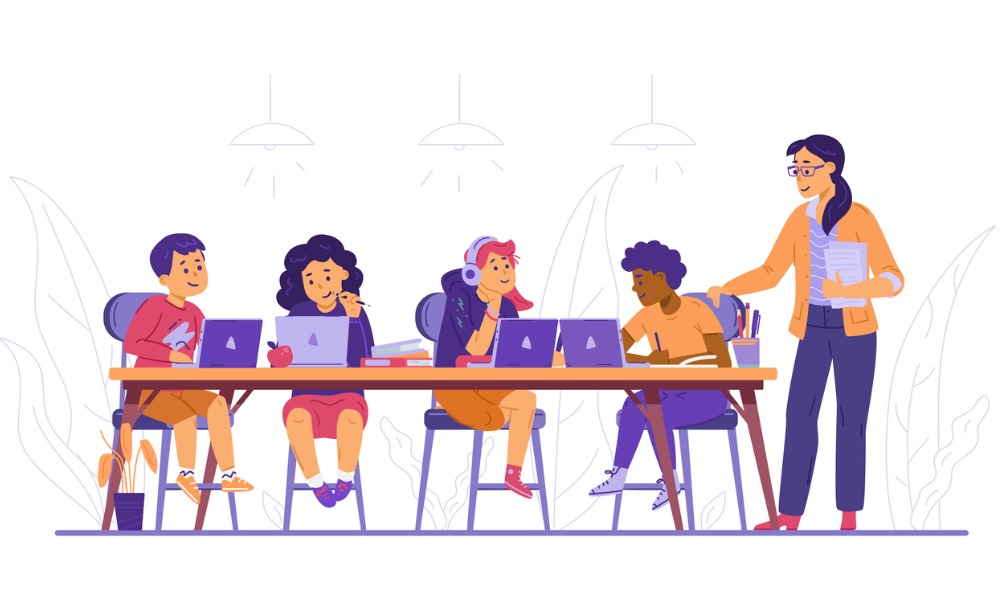Sostegno scolastico: quali sono i passaggi per ottenerlo? L’assegnazione del sostegno scolastico è un processo guidato da normative specifiche che puntano a garantire agli alunni con disabilità il diritto a un’educazione inclusiva. In questo articolo analizzerò i due principali strumenti atti a garantire questo diritto, ovvero il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e il PEI (Piano Educativo Individualizzato) a darò qualche utile consiglio ai genitori dei bambini con disabilità per tutelarsi al meglio IL GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) Normativa di riferimento La costituzione e le funzioni del GLO trovano fondamento nella Legge 104/1992, all’art. 15, comma 10, norma che prevede che presso ogni istituto scolastico venga istituito un gruppo di lavoro per l’inclusione degli alunni con disabilità. Successivamente, il Decreto legislativo 66/2017 (art. 3) e il D.Lgs. 96/2019 hanno introdotto modifiche che precisano la composizione del GLO e delineano con maggiore chiarezza il ruolo di questo gruppo nel processo di inclusione scolastica, in linea con i principi di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia. Composizione del GLO In base all’art. 15 della Legge 104/1992 e alle modifiche del D.Lgs. 66/2017, il GLO è composto dai docenti della classe (inclusi quelli di sostegno), dai genitori dell’alunno o da chi esercita la responsabilità genitoriale, e da figure professionali specifiche, interne o esterne alla scuola, che contribuiscono al percorso educativo dell’alunno, per esempio terapisti privati. Il gruppo è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, che ha il compito di coordinare gli incontri e assicurare che le decisioni prese rispettino il quadro normativo. Altre figure professionali: possono essere coinvolti professionisti come terapisti, rappresentanti dell’ASL e assistenti per l’autonomia e la comunicazione. Al GLO partecipa anche l’UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare) dell’ASL competente che il compito di collaborare con il GLO e di fornire il “necessario supporto”. Funzioni e Compiti del GLO A norma del D.Lgs. 66/2017, art. 7, il GLO è responsabile della redazione, approvazione e revisione periodica del PEI dell’alunno. Questo documento, come vedremo tra poco, è essenziale per definire le strategie didattiche e organizzative di sostegno e per stabilire gli obiettivi educativi dell’alunno. Tra i compiti principali del GLO vi è anche la valutazione delle risorse necessarie per garantire un ambiente di apprendimento inclusivo, come il numero di ore di sostegno e le altre misure compensative (es. addetto all’assistenza, addetto alla comunicazione, ecc.). Quando si riunisce il GLO? Inizio dell’anno scolastico: Secondo l’art. 7 del D.Lgs. 66/2017, il GLO si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per definire e approvare il PEI, entro e non oltre il mese di ottobre. Questo incontro stabilisce le basi per il supporto educativo dell’alunno per l’intero anno. Incontri periodici di verifica: Nel corso dell’anno scolastico, il GLO si riunisce periodicamente (come previsto dall’art. 7, comma 2, lettera h) per verificare i progressi dell’alunno e aggiornare il PEI se necessario. Questi incontri possono essere calendarizzati o convocati su richiesta dei membri del GLO, ad esempio per affrontare emergenze o problematiche specifiche. Incontro finale: A giugno, il GLO si riunisce per una verifica conclusiva del PEI e per formulare le proposte di sostegno per l’anno successivo. Questo incontro finale serve anche a valutare l’efficacia degli interventi applicati durante l’anno scolastico. Coinvolgimento della Famiglia e dell’Alunno La partecipazione attiva della famiglia è un pilastro del GLO, come specificato dall’art. 1 del D.Lgs. 66/2017. I genitori contribuiscono alla definizione del PEI, fornendo informazioni preziose sulla vita dell’alunno fuori dalla scuola, e partecipano alla valutazione periodica dei progressi scolastici. Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, il GLO garantisce anche il diritto di partecipazione diretta dell’alunno, in rispetto del principio di autodeterminazione previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/2009. ATTENZIONE! L’incontro del GLO viene sempre verbalizzato, anche se non sempre la verbalizzazione è contestuale. Quindi è opportuno che i genitori esplicitino le loro richieste, anche se in contrasto con le indicazioni della Scuola (ad es. indicare sempre quante ore di sostegno si ritiene debbano essere attribuite al proprio figlio, idem per le ulteriori misure compensative, o assistenza igienica) chiedendo che vengano comunque verbalizzate. Il verbale del GLO è un documento che deve essere poi condiviso e consegnato ai genitori che ne fanno richiesta. IL PEI (Piano Educativo Individualizzato) Cos’è Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento fondamentale per definire e monitorare le misure di sostegno e inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La sua redazione e implementazione è regolata da normative specifiche, che ne delineano la struttura, i contenuti e le modalità di aggiornamento. Quadro Normativo di Riferimento Il PEI trova il suo fondamento nella Legge 104/1992 (art. 12, comma 5), che riconosce il diritto allo studio per le persone con disabilità e che, appunto, introduce la necessità di un piano educativo personalizzato. Ulteriori disposizioni sul PEI sono contenute nel Decreto legislativo 66/2017 (modificato dal D.Lgs. 96/2019), che descrive in dettaglio le modalità di stesura, approvazione e revisione periodica del PEI. In particolare, l’articolo 7 di questo decreto stabilisce i contenuti e le finalità di questo strumento, prevedendo anche l’interazione con il Progetto Individuale definito dalla Legge 328/2000. Finalità e Struttura del PEI Il PEI è redatto con l’obiettivo di garantire un percorso educativo e didattico inclusivo, che si adatti alle esigenze specifiche dell’alunno e promuova il suo sviluppo personale e l’autonomia. Struttura del PEI: il documento è organizzato in sezioni che coprono aspetti essenziali dell’inclusione scolastica, tra cui: Quadro informativo: raccoglie informazioni sulla vita e le abitudini dell’alunno, provenienti sia dalla famiglia che dagli specialisti coinvolti. Profilo di Funzionamento: redatto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’ASL, rappresenta la base per individuare le aree di intervento educativo, descrivendo le caratteristiche funzionali dell’alunno (art. 5 del D.Lgs. 66/2017). Obiettivi educativi e didattici: definisce le competenze e le abilità che l’alunno dovrebbe acquisire, personalizzando il curriculum scolastico e stabilendo strategie didattiche specifiche. Osservazioni sul contesto: identifica barriere e facilitatori all’apprendimento, valutando i fattori ambientali e sociali che possono influenzare il percorso dell’alunno. Interventi specifici: descrive i metodi e gli strumenti utilizzati per il supporto dell’alunno, includendo l’uso di
Indennità e pensioni per minori invalidi, ciechi e sordi
Vediamo in questo articolo quali sono i riconoscimenti economici dovuti per la condizione di invalidità, cecità e sordità nel bambino. Per le definizioni e le differenze tra le diverse condizioni, si rimanda all’articolo di approfondimento Invalidità, cecità e sordità: definizioni e differenze Provvidenze economiche invalidità civile Al minore invalido civile possono essere riconosciute, alternativamente, le seguenti provvidenze economiche: Indennità di accompagnamento: L. 18/80 e L. 508/88 Indennità di frequenza: L. 289/90 Vediamole di seguito nel dettaglio. 1 – Indennità di accompagnamento Viene concessa al minore che si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di assistenza continua. Viene corrisposta per 12 mensilità È pari, per il 2023, ad € 527,16 È indipendente dal reddito (personale del minore) È incompatibile con l’indennità di frequenza È incompatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato 2 – Indennità di frequenza Viene concessa al minore che presenti delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età È subordinata alla frequenza continuativa o periodica presso centri diurni, centri ambulatoriali o scuole di ogni ordine e grado (compreso l’asilo nido) e viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (va presentata idonea documentazione che lo attesti) È pari, per il 2023, ad € 313,91 È subordinata al limite di reddito (personale del minore) pari, per il 2023, ad € 5.391,88’ incompatibile con l’indennità di accompagnamento È incompatibile con l’indennità di comunicazione Provvidenze economiche cecità civile Al minore cieco civile possono essere riconosciute le seguenti provvidenze economiche: Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: L. 508/88 Indennità speciale per ciechi parziali: L. 508/88 Pensione per ciechi parziali: L. 66/62 e L. 33/80 Vediamole ora nel dettaglio. 1 – Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti Viene concessa al minore cieco assoluto Viene corrisposta per 12 mensilità È pari, per il 2023, ad € 959,21 È indipendente dal reddito (personale del minore) È incompatibile con l’indennità di frequenza È compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili (solo se la patologie per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento è diversa da quella che ha provocato la cecità). Vedi infra il concetto di pluriminorazione. 2 – Indennità speciale per ciechi parziali Viene concessa al minore cieco parziale Viene corrisposta per 12 mensilità È pari, per il 2023, ad € 217,64 È indipendente dal reddito (personale del minore) È incompatibile con l’indennità di frequenza È compatibile e cumulabile con la pensione per ciechi parziali È compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato 3 – Pensione per ciechi parziali Viene concessa al minore cieco parziale Viene corrisposta per 13 mensilità È pari, per il 2023, ad € 313,91 È subordinata al limite di reddito (personale del minore) pari, per il 2023, ad € 17.920,00 È incompatibile con l’indennità di frequenza È compatibile e cumulabile con l’indennità speciale per ciechi parziali È compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato Provvidenze economiche sordità civile Al minore sordo civile può essere riconosciuta la seguente provvidenza economica: Indennità di comunicazione: L. 508/88 Viene concessa al minore sordo, ovvero con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (ovvero fino ai 12 anni) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato Viene corrisposta per 12 mensilità È pari, per il 2023, ad € 261,11 È indipendente dal reddito del minore È incompatibile con l’indennità di frequenza È compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato È compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per l’invalidità civile o la cecità (nel caso, quindi, di soggetti pluriminorati) Cumulo delle provvidenze economiche per pluriminorazioni I soggetti pluriminorati sono quei soggetti che presentano contemporaneamente più minorazioni invalidanti. Essi hanno diritto al riconoscimento dei loro diversi status di invalidità. Ciò significa che, per diverse patologie, la stessa persona può ottenere più riconoscimenti di invalidità civile (ad esempio invalidità civile e cecità assoluta civile, invalidità civile e sordità civile, malattia genetica e cecità parziale civile, ecc.) e, di conseguenza, ha diritto di beneficiare al cumulo delle diverse provvidenze economiche spettanti. (L. 429/91 e sent. Corte Cost. 346/89). Riassumendo, il principio legislativo vigente è quello della generale ammissibilità del cumulo, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Per esempio, è preclusa espressamente, anche in caso di pluriminorazioni, la concessione dell’indennità di frequenza per coloro che sono titolari dell’indennità di accompagnamento come invalidi civili, dell’indennità di accompagnamento come ciechi civili assoluti, dell’indennità di comunicazione come sordi e dell’indennità speciale come ciechi civili parziali (art. 3 L. 289/90). Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole. [Foto di Nataliya Vaitkevich]
Permessi lavorativi L.104/92 e part time verticale
PERMESSI LAVORATIVI PREVISTI DALLA LEGGE 104/92 E DISCIPLINA DEL PART-TIME L’art. 33 della L. 104/92 prevede espressamente che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Nulla quaestio quando il rapporto di lavoro instaurato è a tempo pieno. Ma cosa succede se la tipologia di lavoro prestata è a part-time, ovvero con orario ridotto rispetto al tempo pieno? Per prima cosa vanno distinte le tre tipologie di part-time esistenti: Part-time orizzontale: è quello “classico” che prevede mezza giornata lavorativa (ad esempio dalle 8.30 alle 12.30 oppure dalle 14.30 alle 18.30) Part-time verticale: è quello che prevede che il lavoratore lavori a tempo pieno (es. 8 ore) ma solo per alcuni giorni alla settimana (ad esempio 3), o anche limitatamente ad alcune settimane o alcuni mesi. A maggiore esemplificazione è part-time verticale quello in cui il lavoratore presta attività dal lunedì al mercoledì a tempo pieno, mentre non lavora i restanti giorni della settimana. Part-time misto: è un mix tra il part-time orizzontale e quello verticale; il lavoratore, per esempio, può lavorare ad orario ridotto solo per qualche giorno alla settimana. COME VIENE DISCIPLINATO IL LAVORO PART-TIME VERTICALE CON I PERMESSI GIORNALIERI PREVISTI DALLA L. 104 PER ASSISTERE LA PERSONA CON GRAVE DISABILITA’? Nessun problema nel part-time orizzontale dove i 3 giorni previsti per legge sono garantiti. Nel part-time verticale (ma anche quello misto segue la stessa disciplina), invece, possono sorgere problemi: spesso i datori di lavoro riproporzionano (ovvero riducono) i 3 giorni lavorativi spettanti al lavoratore, applicando dei parametri di calcolo indicati in circolari diramate da INPS. Accade quindi sovente che il dipendente con contratto di lavoro di tipo part-time verticale si veda attribuire solo 1 o 2 giorni di permesso, anziché 3 o, parimenti, che il lavoratore già dipendente a tempo pieno e con fruizione dei 3 giorni, se li veda decurtare una volta passato al part-time verticale. Tali prassi, benché indicate nelle varie circolari INPS con tanto di coefficienti di calcolo, sono nella maggior parte dei casi illegittime. Se è vero che non esiste una disposizione specifica di legge che regolamenti espressamente la tipologia di part-time verticale, è altrettanto vero che in questi casi soccorrono i principi vigenti nel nostro ordinamento, tra tutti quello di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale. Ma soprattutto ciò che si impone è una interpretazione della norma in senso costituzionale e coerente alle indicazioni comunitarie e internazionali in tema di tutela della disabilità. La finalità della norma è, infatti, quella di favorire l’assistenza alla persona affetta da grave handicap in ambito familiare e di salvaguardare il suo diritto alla salute, inteso come diritto fondamentale dell’individuo. LA CASSAZIONE SI E’ PRONUNCIATA SUI PERMESSI LAVORATIVI NEL PART-TIME VERTICALE Questi sono i principi che la Suprema Cassazione ha fatto propri in alcune recenti sentenze, pronunciandosi in casi in cui i lavoratori sono ricorsi in giudizio per tutelare i loro diritti. I Giudici della Cassazione civile, sulla base delle considerazioni sintetizzate poco sopra, sono giunti a riconoscere che il lavoratore part-time verticale debba poter fruire di 3 giorni di permesso, al pari degli altri lavoratori. La Cassazione, tuttavia, ha adottato un “correttivo” al fine di evitare che la fruizione dei permessi del part-time verticale possa tradursi in un “irragionevole sacrificio per la parte datoriale”. Per contemperare le esigenze del lavoratore con quelle di produttività del datore di lavoro rispetto alla particolare articolazione della prestazione lavorativa, la Corte di Cassazione ha ritenuto ragionevole operare il seguente distinguo: 1) se le giornate di lavoro part-time (articolate su base settimanale) superano il 50% delle giornate che sarebbero previste se il lavoro fosse full-time, si ha integrale diritto alla fruizione dei permessi (quindi 3 giorni). 2) se, invece, le giornate di lavoro part-time (articolate su base settimanale) sono inferiori al 50% delle giornate di lavoro a tempo pieno, o limitate ad alcuni periodi dell’anno, allora i permessi potranno essere legittimamente riproporzionati. Esempi: – il lavoratore che lavora 4 giorni su 6, siccome lavora più del 50% rispetto alle giornate in cui lavorerebbe se fosse a tempo pieno, ha diritto di fruire dei 3 giorni di permesso; – il lavoratore che lavora 2 giorni su 5, siccome lavora meno del 50% rispetto alle giornate in cui lavorerebbe a tempo pieno, può vedersi legittimamente riproporzionati i giorni di permesso dal proprio datore di lavoro. Inoltre la Cassazione ha stabilito che meritano accoglimento le domande di risarcimento del danno svolte dai ricorrenti i quali, quindi, si sono quindi visti risarcire il danno subito (secondo criteri equitativi) con una somma di denaro calcolata per ogni giorno di permesso illegittimamente non fruito. CHIARIMENTI SULLA CONCESSIONE DEI PERMESSI LAVORATIVI: CHI LI EROGA? L’art. 33 della L. 104/92 stabilisce che è il datore di lavoro (e non dunque l’INPS) ad erogare i giorni di permesso, in quanto la domanda del lavoratore investe un profilo inerente il rapporto di lavoro. Tant’è che, come spesso accade, quando il lavoratore a tempo pieno -già fruitore dei 3 giorni di permesso- modifica il suo rapporto di lavoro trasformandolo a part-time di tipo verticale, è il datore di lavoro, e non l’INPS, a riproporzionare i permessi. Quindi in controversie di questo tipo dobbiamo rivolgerci al datore di lavoro. Diversamente accade quando è INPS ad escludere preventivamente il diritto del lavoratore a poter fruire dei permessi. In un caso in cui un padre di due gemelli con handicap grave aveva chiesto il doppio dei permessi in ragione del fatto che i figli erano due, è stata riconosciuta la legittimazione passiva dell’INPS, non tanto in quanto soggetto obbligato al riconoscimento dei permessi, ma in quanto soggetto
Separazione e mantenimento figli: le spese straordinarie vanno rimborsate anche se manca l’accordo
Spese straordinarie: quali sono Le spese straordinarie sono quelle che non sono conteggiate nell’assegno periodico dovuto al genitore per il mantenimento ordinario dei figli. L’assegno di mantenimento, infatti, è destinato a soddisfare le esigenze della vita quotidiana dei minori e copre spese quali quelle per l’alimentazione o quelle per i farmaci da banco: in questo caso si parla di spese ordinarie. Le spese straordinarie, invece, sono quelle che riguardano aspetti imprevedibili o comunque non ricorrenti e non determinabili in anticipo, ma che possono anche essere di notevole entità. Esse, dunque, debbono essere rimborsate nella misura del 50% al genitore che le sostiene . Per esempio, sono straordinarie le spese dentistiche, le spese mediche specialistiche, le spese per la retta della scuola privata. Tra genitori separati o divorziati le spese straordinarie per i figli devono essere necessariamente concordate? Il genitore affidatario o collocatario deve obbligatoriamente concordare con l’altro genitore le spese straordinarie relative ai figli? La Corte di Cassazione è tornata recentemente ad affrontare il tema con le ordinanze n. 16175/2015 e n. 4182/2016 confermando l’orientamento già espresso in materia dalla Suprema Corte. Il genitore con cui i figli convivono, non solo, non ha alcun obbligo di concertazione preventiva con l’altro genitore in merito alla determinazione delle spese straordinarie, ma nemmeno è tenuto ad informarlo. Sembrerebbe un precetto ingiusto, eppure il principio è sempre quello del preminente interesse dei figli che potrebbero subire un pregiudizio ogni qualvolta i genitori non siano in grado di accordarsi. Quindi, il genitore che non ha concordato le spese con l’altro, non per questo perde il diritto al rimborso. Tuttavia, le spese, per essere sicuramente rimborsabili, devono essere: utili per il minore proporzionate alle capacità economiche dei genitori Cosa fare quando il genitore si rifiuta di rimborsare all’altro genitore le spese straordinarie non concordate? L’ultima parola spetta sempre al Giudice che dovrà valutare se la spesa contestata sia di utilità per il minore e se essa sia effettivamente sostenibile in relazione alle condizioni economiche dei genitori. Se, infatti, il genitore che rifiuta il rimborso è in grado di dimostrare di trovarsi nell’impossibilità economica di farvi fronte, il Giudice potrà anche non autorizzare il rimborso di quella spesa. Riferimenti Ord. Cass. 16175/2015 – Ord. Cass. 4182/2016
Prolungamento della scuola dell’infanzia per bambini con disabilità
Un bambino con disabilità può permanere nella scuola dell’infanzia (ex scuola materna) oltre il 6° anno di età? La legge n. 53/03 prevede che al 6° anno di età tutti i bambini debbano iniziare a frequentare la scuola primaria (ex elementare). Ma questo vale anche per i bambini con disabilità? In effetti la questione è di notevole rilevanza anche dal punto di vista etico: è meglio a far permanere il bambino disabile presso la scuola dell’infanzia dopo il compimento del 6° anno di età in considerazione delle sue capacità naturali o, invece, è più giusto il passaggio alla scuola primaria insieme ai compagni di asilo? Fino a qualche tempo fa, seppure in modo non uniforme nel territorio nazionale, si ammetteva la possibilità di derogare alla L. 53/03 e quindi di consentire la permanenza del bambino alla scuola dell’infanzia oltre il 6° anno di età, per un tempo non precisato. Infatti, la circolare ministeriale n. 235/75, che dettava istruzioni operative per l’iscrizione alla scuola materna di bambini handicappati, non precisava alcun limite di permanenza: in buona sostanza la nota chiariva che per il bambino con disabilità non doveva essere presa in considerazione l’età anagrafica, ma quella mentale, e demandava ogni decisione sulla permanenza scolastica al Collegio dei docenti con la partecipazione di specialisti dell’area medica e socio-pedagogica. Recentemente, invece, il MIUR ha emanato la circolare n. 547/2014 che ha preso una precisa posizione sul tema chiarendo in modo non più interpretabile che gli alunni che necessitano di speciale attenzione possano permanere presso la scuola dell’infanzia oltre il 6° anno di età solamente in presenza di queste condizioni: in casi eccezionali e debitamente documentati, su decisione del Dirigente scolastico per un tempo non superiore ad un anno scolastico Questa circolare è andata a sostituire una circolare emanata poche settimane prima, la n. 338/2014, che aveva sollevato numerose critiche da parte delle rappresentanze delle persone con disabilità: essa era stata emanata per giustificare la permanenza nella scuola dell’infanzia oltre il 6° anno di età di bambini adottati, in considerazione del livello cognitivo e socio-affettivo da loro raggiunto. La nota, però, richiamava esemplificativamente la circolare n. 235/75 per giustificare la permanenza a scuola oltre il 6° anno anche dei bambini disabili. Proprio questo richiamo aveva aperto un’aspra polemica da parte della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) che riteneva, per contro, il contenuto della circolare n. 235/75 del tutto superato con l’entrata in vigore della L. 53/03 che aveva sancito l’inizio dell’obbligo scolastico al 6° anno di età. Il dubbio interpretativo in materia veniva subito fugato dal MIUR con la citata circolare n. 547/2014 emanata poche settimane dopo la precedente: in essa veniva eliminato qualsiasi richiamo alla vecchia circolare n. 235/75. Riferimenti normativi L. 53/03 – D.Lgs. 59/04 – D.Lgs. 297/94 – C.M. 235/75 – Circ. Miur n. 338/14 – Circ. Miur 547/14
Quali sono i riconoscimenti economici a favore dei bambini disabili?
Disabili Minorenni: indennità e pensioni dovute Il minore con disabilità ha diritto ad una serie di erogazioni di denaro a seconda del tipo di minorazione riconosciuta. Esistono quindi provvidenze specifiche per il minore invalido, per il minore cieco e per il minore sordo. Vediamole nel dettaglio, scoprendo gli eventuali divieti di cumulo e i limiti di reddito, se previsti. Minore invalido civile Il bambino riconosciuto invalido civile ha diritto a percepire, in via alternativa, l’indennità di accompagnamento o l’indennità di frequenza. 1. Indennità di accompagnamento: Viene concessa al minore che si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di assistenza continua Viene corrisposta per 12 mensilità E’ pari ad € 512,34 (anno 2016) E’ indipendente dal reddito (personale del minore) E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ incompatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato 2. Indennità di frequenza viene concessa al minore che presenti delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età E’ subordinata alla frequenza continuativa o periodica presso centri diurni, centri ambulatoriali o scuole di ogni ordine e grado (compreso l’asilo nido) e viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (va presentata idonea documentazione che lo attesti) E’ pari ad € 279,47 (anno 2016) E’ subordinata al limite di reddito (personale del minore) pari ad € 4.800,38 (anno 2016) E’ incompatibile con l’indennità di accompagnamento E’ incompatibile con l’indennità di comunicazione Minore cieco civile Al minore riconosciuto cieco civile possono essere erogate l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, l’indennità speciale per ciechi parziali, la pensione per ciechi parziali. 1. Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti Viene concessa al minore cieco assoluto Viene corrisposta per 12 mensilità E’ pari ad € 899,38 (anno 2016) E’ indipendente dal reddito (personale del minore) E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili (solo in caso di pluriminorazione, ovvero solo se la patologia per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento è diversa da quella che ha provocato la cecità). 2. Indennità speciale per ciechi parziali Viene concessa al minore cieco parziale Viene corrisposta per 12 mensilità E’ pari ad € 206,59 (anno 2016) E’ indipendente dal reddito (personale del minore) E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ compatibile e cumulabile con la pensione per ciechi parziali E’ compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato 3. Pensione per ciechi parziali Viene concessa al minore cieco parziale Viene corrisposta per 13 mensilità E’ pari ad € 279,47 (anno 2016) E’ subordinata al limite di reddito (personale del minore) pari ad € 16.532,10 (anno 2016) E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ compatibile e cumulabile con l’indennità speciale per ciechi parziali E’ compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato Minore sordo civile Al bambino sordo civile può essere riconosciuta l’indennità di comunicazione. 1. indennità di comunicazione viene concessa al minore sordo, ovvero con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (ovvero fino ai 12 anni) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato viene corrisposta per 12 mensilità E’ pari ad € 254,39 (anno 2016) E’ indipendente dal reddito del minore E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato. E’ compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per l’invalidità civile o la cecità (nel caso, quindi, di soggetti pluriminorati) Riferimenti normativi: L. 18/1980 – L. 508/1988 – L. 289/1990 – L. 66/1962 – L. 33/1980
Chi ha diritto a percepire gli assegni familiari in caso di separazione o divorzio?
Assegni per il nucleo familiare: cosa succede in caso di separazione o divorzio? Va fatta una distinzione a seconda delle modalità regolatrici l’affidamento dei figli: Affidamento esclusivo Se i figli sono affidati ad un solo genitore, sarà proprio quel genitore ad averne diritto: solo il genitore affidatario è legittimato a richiedere e percepire l’assegno per il nucleo familiare. In pratica il genitore affidatario costituisce un nuovo “nucleo familiare” insieme ai figli lui affidati. L’affidamento esclusivo, tuttavia, ha carattere residuale: con l’introduzione nel 2006 dell’affido condiviso e del principio della bigenitorialità, i figli vengono generalmente affidati ad entrambi i genitori, a meno che non ci siano gravi motivi ostativi a questo tipo di affidamento. Affidamento condiviso Se i figli sono affidati ad entrambi i genitori, come normalmente avviene dall’entrata in vigore della L. 54/2006, entrambi i genitori sono legittimati a richiedere gli assegni per il nucleo familiare perché è come se ciascun genitore formasse un nuovo “nucleo familiare” a sé stante. Ferma questa astratta facoltà, di fatto, poi, solo uno dei due genitori può richiederli e percepirli. I genitori possono già in fase di separazione o divorzio consensuali prevedere quale dei due possa richiederli. Nel caso, invece, in cui i genitori non raggiungano un accordo, allora il criterio legislativo cui il Giudice si atterrà è quello della convivenza: essi spetteranno al genitore che convive stabilmente con i figli. Ho diritto agli assegni familiari anche se non lavoro? Anche il genitore che di per sé non ha diritto alla percezione degli assegni familiari -per esempio perché non è lavoratore o non è titolare di pensione- ma che convive con i figli, può sostituirsi nella posizione dell’ex coniuge o compagno avente diritto alla corresponsione dei suddetti assegni, e richiederne ed ottenerne l’erogazione. Questa tutela opera anche nel caso di genitori non coniugati. Unica differenza: se si tratta di genitori coniugati, essi vengono erogati avendo a riguardo la situazione reddituale dell’avente diritto (quindi del coniuge che non convive con i figli); se si tratta di genitori non coniugati, invece, si terrà conto della situazione reddituale del genitore che convive con i figli. Dopo la separazione/divorzio ho iniziato a percepire gli assegni di mantenimento: mio marito/mia moglie ha diritto ad avere un abbassamento dell’importo dell’assegno che mi sta pagando? Gli assegni familiari costituiscono una misura a sostegno del reddito: hanno natura prettamente alimentare e, pertanto, non vanno conteggiati come reddito ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli dovuto dall’altro coniuge/compagno. Per esempio, se Tizio percepisce € 800,00 al mese di stipendio ed € 200,00= di assegni familiari, l’assegno di mantenimento per i figli che convivono con la madre Caia dovrà essere determinato sulla somma mensile di € 800,00= (effettiva capacità contributiva di Tizio) perché la somma mensile di € 200,00= (assegni per il nucleo familiare) verrà percepita direttamente da Caia (genitore con cui convivono i figli). Sono sempre validi i diversi accordi che i genitori abbiano di comune accordo stabilito in sede di separazione o divorzio. Riferimenti: art. 30 co. 3 D.lg.s. 198/2006 art. 211 L. 151/1975 D.L. n. 69/1988 conv. L. n. 153/1988 Cass. Civ. n. 12770/2013 Circ. Inps n. 210/1999